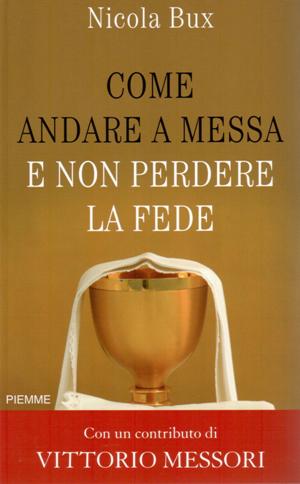di Daniele Di Sorco

1. La difficoltà aggregativa.
Chi ha la fortuna di ottenere una nuova celebrazione regolare nella forma straordinaria, si trova quasi sempre di fronte a un problema imprevisto e apparentemente insormontabile: la difficoltà di aggregare un ragionevole numero di fedeli e soprattutto di farlo crescere. Normalmente le cose vanno in questo modo. La prima volta, grazie alla novità dell’evento e alla solerzia degli organizzatori nell’invitare amici e conoscenti, si ottiene una partecipazione piuttosto cospicua. Essa, poi, decresce progressivamente, fino ad assestarsi, dopo circa un mese (se la celebrazione ha cadenza settimanale), su una media di circa trenta persone: poco più o poco meno a seconda della grandezza del centro abitato.
Questo fenomeno, che si verifica con puntualità sistematica ogni volta che si riesce ad avviare un nuovo (per usare un’espressione molto in voga) “centro di Messa”, scoraggia molti, sorprende tutti, appare inspiegabile a chi conosce, sia pur superficialmente, la situazione di altri Paesi europei, dove la frequenza alla Messa tradizionale è assai più significativa che in Italia. Tuttavia, se vogliamo che la conoscenza e la diffusione della liturgia in forma straordinaria si espanda e raggiunga strati sempre più ampi di fedeli, non dobbiamo fermarci alla fase dello scoraggiamento e dello stupore, ma interrogarci sulle cause del problema e individuare le soluzioni adatte per risolverlo.
2. Quali cause?
Non mi addentro nell’analizzare le ragioni storiche che hanno contribuito a creare nei fedeli una mens di per sé poco propensa verso la liturgia antica, in parte perché ritengo che siano abbastanza note, e in parte perché non rientrano nello scopo di questo contributo. L’abbandono della catechesi liturgica e la denigrazione della forma storica del rito romano sono state due costanti del periodo postconciliare fino al pontificato di Benedetto XVI.
Tutto ciò ha avuto in Italia conseguenze più disastrose che altrove, poiché, mentre nei Paesi francofoni e germanofoni il movimento liturgico era riuscito, fin dal primo dopoguerra, ad impartire al popolo una istruzione liturgica di medio livello, in Italia si cominciò a fare qualche passo nella medesima direzione solo a partire dagli anni Cinquanta. Le conseguenze sono facilmente immaginabili: l’ignoranza del rito storico da un lato, e la sua denigrazione dall’altro, hanno fatto sì che oggi la maggioranza dei cattolici italiani abbia serie difficoltà nell’apprezzare le caratteristiche della liturgia che la Chiesa ha ininterrottamente celebrato fino alla fine degli anni Sessanta.
Un altro problema è senza dubbio costituito dall’ostracismo di tanta parte del clero nei confronti della liturgia antica. Molti fedeli, specialmente quelli che hanno conosciuto la Messa tradizionale in gioventù, sono ben contenti di potervi nuovamente partecipare, ma il loro desiderio incontra non di rado un serio ostacolo nell’atteggiamento, per esempio, del parroco, che non si fa scrupolo di sconsigliare la frequenza alla Messa in forma straordinaria, tacciata di arretratezza, accusata di fomentare divisioni all’interno della Chiesa o indebitamente associata a istituti non in piena comunione con la Santa Sede. Poiché la persona media si fida ancora dell’opinione del proprio parroco o del proprio sacerdote di fiducia, il parere negativo di costoro influisce non poco sulla decisione di partecipare o non partecipare alle funzioni in forma straordinaria. Contro una tendenza del genere, i laici o anche le associazioni di laici possono fare ben poco, se non denunciare i casi più gravi alla competente autorità ecclesiastica.
A ciò deve aggiungersi la notevole difficoltà che si incontra nel divulgare la notizia della celebrazione in forma straordinaria al di là della cerchia degli amici e dei conoscenti o delle persone già in precedenza interessate. Il recente sontaggio effettuato dall’istituto Doxa ha rilevato come appena poco più della metà dei cattolici praticanti italiani conosce l’esistenza di una forma straordinaria del rito romano. Una situazione certamente non destinata a migliorare nel breve periodo, visto l’atteggiamento ostile di buona parte del mondo ecclesiastico. E se non c’è conoscenza, non può esserci neppure interessamento: nihil volitum, quin cognitum. Anche i parroci e i rettori che non sono a priori contrari accettano di mala voglia che nella bacheca delle loro chiese si affiggano notizie relative alla Messa tradizionale: non vedono di buon occhio la possibilità che qualcuno dei loro fedeli frequenti una realtà diversa da quella parrocchiale.
3. In che cosa precisamente consiste il problema.
La capacità della Messa tradizionale di aggregare fedeli, inoltre, è proporzionale alla correttezza e al fervore con cui viene celebrata. I documenti apostolici precedenti al Concilio che toccano la questione della partecipazione attiva sono concordi nell’affermare che essa ha come presupposto una funzione perfettamente conforme alle rubriche. “L’esempio principale [di partecipazione attiva] è offerto dal sacerdote celebrante e dai suoi ministri, i quali servono all’altare con la dovuta pietà interna e con l’esatta osservanza delle rubriche e cerimonie” (Sacra Rituum Congregatio, Instructio de Musica sacra et de sacra Liturgia, 3 sett. 1958, n. 22).
Le ragioni sono intuitive. La liturgia ha il fine di elevare il popolo al divino, non di abbassare il divino al livello del popolo. I riti, pertanto, devono svolgersi dappertutto allo stesso modo e non possono essere modificati o adattati alle esigenze, vere o presunte, della comunità locale. Diversamente si scade in quel particolarismo che costituisce uno dei più gravi difetti della liturgia riformata e che non consegue alcun risultato sul piano pastorale, poiché l’unità della preghiera corrisponde all’unità della fede. Le statistiche dimostrano che l’esodo dalle chiese è cominciato proprio quando il rito, da universale e stabile, si è trasformato in particolare e variabile.
Ora, non è un mistero che moltissime delle attuali Messe in forma straordinaria si caratterizzano per la molteplicità di abusi o per la negligenza e la superficialità con cui vengono osservate le norme. Ciò avviene talvolta in mala fede, nel caso in cui al celebrante interessi poco o nulla del rito tradizionale, talaltra e più spesso in buona fede, quando il sacerdote crede, mettendo in pratica quegli adattamenti che egli ritiene opportuni, di agevolare la partecipazione popolare.
Abbiamo visto poco sopra come questo atteggiamento, oltre ad essere contrario alle leggi ecclesiastiche, che riservano esclusivamente alla Santa Sede la regolazione del rito e dei singoli suoi particolari, non porta ad alcun risultato positivo. Esso risente della mentalità tipica della liturgia riformata e fa della forma straordinaria qualcosa di altrettanto variabile e adattabile che la forma ordinaria. In questo modo ai fedeli è impossibile conoscere la liturgia antica nella sua vera essenza.
Opposto a questo, ma non meno dannoso, è l’atteggiamento di chi non si preoccupa in alcun modo di curare la partecipazione attiva dei fedeli. Molti, una volta ottenuta la celebrazione regolare, non si interessano più del suo funzionamento e lasciano che la cosa vada avanti per forza di inerzia. Non è raro assistere, anche nei giorni festivi, a una Messa completamente piana, dalla quale sono completamente estromesse, non dico le forme moderne e deviate, ma quelle tradizionali e raccomandabili di partecipazione attiva: i libretti bilingue su cui seguire la funzione o mancano del tutto o sono inefficaci, perché privi di indicazioni spirituali e pastorali; il canto, sia quello liturgico che quello popolare, è assente, come pure il suono dell’organo; il servizio all’altare, quando c’è, si caratterizza per sciattezza e superficialità.
Cose del genere sono forse sopportabili nella forma ordinaria, dove la lingua volgare e la familiarità dei riti suppliscono alla povertà esteriore della cerimonia, ma risultano deleterie nella forma straordinaria, che fa della sacralità del rito e dell’apparato con cui si celebra uno dei suoi punti di forza.
4. Disorganizzazione e disunione.
La rassegna dei problemi va conclusa con quello che, a mio avviso, è il principale e dal quale derivano tutti gli altri: l’incapacità di dare vita ad una vera e propria comunità. O, se si vuole, l’incapacità di costruire qualche cosa che vada oltre la Messa, pur conservando la Messa come centro e trait d’union. Non bisogna dimenticare che la liturgia in forma straordinaria non è che una componente, importantissima ma pur sempre una componente, del più vasto ambito della Tradizione cattolica. Molti, invece, tendono a farne un traguardo al di là del quale non importa andare. Su questo punto bisogna intendersi.
Mi rendo perfettamente conto che, specialmente in alcuni luoghi, riuscire ad ottenere una Messa regolare è già un grande risultato. Né sono all’oscuro che in molti casi le forze a disposizione sono scarse e non consentono di andare oltre un certo limite. Ma il problema della mancanza di coesione e dello scarso attivismo extraliturgico riguarda non solo i centri di Messa in formazione, ma anche quelli esistenti da tempo e ormai ben consolidati.
Tra le cause, bisogna annoverare anzitutto una diffusa mancanza di coraggio e di iniziativa. Si ha l’impressione, certe volte, che i fautori della liturgia tradizionale, forse anche a causa della lunga fase catacombale alla quale sono stati per decenni costretti, abbiano sviluppato una specie di allergia ad occuparsi dei gravi problemi che travagliano la Chiesa di oggi. Non che essi non se ne interessino o non ne parlino. Lo fanno, certo, ma quasi sempre nell’ambito della propria ristretta cerchia, stando ben attenti a non esporsi troppo all’esterno.
Per quanto possa apparire paradossale, ho conosciuto alcune persone che frequentano la Messa tradizionale quasi di nascosto; altre che se ne vergognano; altre ancora che evitano qualunque rapporto con gli altri fedeli che frequentano la funzione. Pochi sono disposti ad assumersi incarichi organizzativi. Pochissimi sono d’accordo con l’idea di iniziative extraliturgiche. Sembra che lo spirito individualista del postconcilio abbia preso piede anche negli ambienti legati alla Tradizione e che molti vedano nella Messa tradizionale nient’altro che un modo per soddisfare le proprie (peraltro legittime) esigenze di ordine spirituale.
È noto che la mancanza di coesione e di unità è una delle cause più formidabili di disgregazione. “Omne regnum in se ipsum divisum, desolabitur“, insegna il Vangelo (Luc. 11, 17). Tale, duole ammetterlo, è la situazione, almeno nel nostro Paese, di molte chiese e cappelle nelle quali si celebra la liturgia tradizionale, col risultato di deludere prima e allontanare poi i potenziali frequentatori. Essi, infatti, cercano nelle realtà legate al rito antico ciò che non riescono più a trovare nelle proprie parrocchie: non solo, quindi, una celebrazione degna della sacra liturgia, ma anche un’occasione per approfondire la dottrina cristiana e condividere con gli altri le proprie riflessioni od esperienze in un ambiente non avvelenato dal secolarismo e dal progressismo. Se in passato le associazioni di fedeli laici, come le confraternite e le pie unioni, hanno avuto un grande successo in termini numerici e spirituali, è proprio perché, oltre al loro fine specifico, hanno saputo valorizzare nel dovuto modo la dimensione aggregativa.
Certo, è impensabile che le realtà legate alla tradizione si pongano come alternativa alle parrocchie. Il motu proprio di Benedetto XVI lo esclude esplicitamente, identificando appunto nella parrocchia il luogo ordinario di celebrazione della forma straordinaria. Ciò non toglie, tuttavia, che esse possano svolgere un ruolo complementare a quello della parrocchia, proprio come le confraternite, favorendo in particolar modo la conoscenza della Tradizione cattolica in ogni suo aspetto, non soltanto liturgico.
Dalla nostra capacità di trasformare, nei modi e nei tempi opportuni, le realtà legate alla tradizione in autentiche comunità, simili al lievito che fa gonfiare la pasta (cfr. Mt. 13, 33), dipende il successo o l’insuccesso della nostra causa.
5. Proposte di soluzione. Il ruolo del clero.
Finora ho cercato di tracciare un quadro abbastanza completo, benché sintetico, dei problemi che determinano un’affluenza di fedeli alla liturgia tradizionale inferiore alle aspettative. Individuare le soluzioni non è lavoro di una persona sola. Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni e proposte, in attesa che altri esaminino la questione e avanzino proposte.
Anzitutto, un’osservazione preliminare. Il ruolo dei laici è senza dubbio importante, ma una reale svolta nell’organizzazione e nella gestione delle funzioni in forma straordinaria potrà avvenire solo quanto il clero comincerà, in modo generale e sistematico, a prendere coscienza dell’importanza dell’iniziativa e ad occuparsene in prima persona. L’esperienza dimostra che nei luoghi in cui è stato il parroco a farsi carico dell’organizzazione e della divulgazione del rito tradizionale, la frequenza dei fedeli risulta significativamente più alta. Per contro, laddove la maggior parte del clero ostenta contrarietà o sufficienza nei confronti della forma straordinaria e inculca una mentalità liturgica ad essa contraria, i gruppi di fedeli laici, per quanto organizzati e coordinati, non possono fare molto.
Nel nostro Paese, infatti, esiste ancora la tendenza di fidarsi ciecamente del parere del clero, specialmente in questioni che riguardano direttamente l’ambito ecclesiastico. Un atteggiamento del genere, nell’odierno contesto, ha vantaggi e svantaggi. Tra gli svantaggi, il rischio di adeguamento ad opinioni discutibili, non conformi alla mente del Santo Padre o addirittura sconfinanti nell’eterodossia. Tra i vantaggi, la possibilità di divulgare su vasta scala posizioni in linea con la Tradizione cattolica. Tutto dipende dalla persona con cui si ha a che fare.
Nell’opinione di chi scrive, quindi, il coinvolgimento sistematico del clero nella causa della liturgia tradizionale costituirà il vero punto di svolta di una situazione altrimenti destinata ad evolversi con molta lentezza. Da questo punto di vista, non è azzardato coltivare buone speranze. Risulta, infatti, che una buona parte del giovane clero è interessata alla questione liturgica e, più in generale, alla riscoperta della Tradizione cattolica nel suo complesso. Grazie ad una nuova ondata di studi liturgici, cominciano a perdere molto del loro vigore quei pregiudizi che hanno portato alla denigrazione delle forme rituali storiche e all’esaltazione smodata e acritica di quelle attuali. Inoltre il crescente interesse verso il rito tradizionale da parte dei fedeli sollecita una risposta adeguata da parte del clero.
In Italia la strada da fare è ancora lunga, ma in Francia i fedeli legati alla forma straordinaria del rito romano rappresentano una porzione molto significativa del totale dei praticanti, ed essendo i più prolifici sul piano vocazionale, sono destinati a divenire, nell’arco di qualche decennio, la maggioranza. Una situazione che i vescovi, volenti e nolenti, non potranno ignorare.
6. Il ruolo dei laici.
In attesa che il clero si decida a fare le sue mosse, però, è evidente che i laici non possono restare inerti. È ad essi che spetta preparare il terreno per un un ritorno più generalizzato della liturgia romana storica, non solo nella pratica ecclesiale, ma anche nella mentalità dei cattolici. Ciò si ottiene non soltanto moltiplicando il numero delle chiese in cui si celebra l’antico rito, ma anche facendo in modo, con tutti gli accorgimenti suggeriti dalle norme ecclesiastiche e dal buon senso, che esso sia officiato in maniera veramente degna, attenta, devota, tale da veicolare ai partecipanti il senso genuino della liturgia. In questo modo sarà facile, anche per i non esperti, sperimentare l’alta spiritualità che caratterizza la liturgia romana classica.
7. Il celebrante.
Il punto di partenza è costituito, naturalmente, dal celebrante. Mi rendo conto che in molte diocesi, nonostante il motu proprio, vige ancora la prassi della nomina episcopale: in questi casi, è necessario accontentarsi, almeno per il momento, di chi si ha a disposizione, anche se si tratta di persone che, per età, preparazione o scarso interesse, si rivelano impari all’incarico loro affidato. Diversamente è opportuno affidarsi a un sacerdote che dimostri vero interesse per il rito antico e sincera disponibilità ad impararne nel dettaglio le norme.
Il modo di celebrare, infatti, riflette in modo assai eloquente la visione che si ha della liturgia e più in generale della religione cattolica. Il sacerdote sciatto, superficiale, disattento, che bada più al funzionamento del microfono che al modo con cui tocca le sacre Specie, non stimola certo pietà o devozione. Invece il sacerdote che è, ed appare anche esteriormente, tutto preso dal rito, dall’azione sacra e da ciò che essa significa, coinvolge anche i fedeli nel suo processo di elevazione verso il divino. Gli effetti sul popolo delle Messe celebrate dai Santi ne sono la prova.
Tutto ciò, com’è evidente, ha come presupposto il rispetto scrupoloso, puntuale e attento delle rubriche. Il rito romano antico non è difficile. Lo è forse rispetto al rito romano riformato, che in molte cose ha rimpiazzato il principio dell’uniformità con quello della creatività, non certo rispetto ai riti orientali, che sono infinitamente più complessi. Il vero scoglio per chi, abituato alla forma ordinaria, si accosta per la prima volta alla forma straordinaria è costituito più dalla mentalità che dalla differenza tra le singole norme. La forma ordinaria ha abituato molti all’idea che, per celebrare in modo decente, sia sufficiente conoscere il rito nelle sue linee generali, affidandosi, per il resto, all’iniziativa personale o a vaghe e indefinite reminescenze.
Naturalmente qui non ci si riferisce ai lapsus o alle distrazioni cui può andare incontro la memoria, ma ad un atteggiamento di programmata e sistematica negligenza verso le prescrizioni dei libri liturgici. È normale, per esempio, scordarsi di espandere le mani durante l’orazione; meno normale trascurare deliberatamente la norma che prescrive questo gesto e regolarsi in base al proprio arbitrio. Un tale modo di pensare, dannoso per la forma ordinaria, per la forma straordinaria è distruttivo, visto che essa, al pari delle altre liturgie storiche, fa dell’uniformità e dell’esattezza rituale il suo punto di forza.
Non meno distruttivo è l’atteggiamento di coloro che, sostituendosi alla Santa Sede, introducono arbitrariamente modifiche e adattamenti nel rito oppure operano improbabili commistioni tra la forma ordinaria e quella straordinaria. In questo modo, la struttura del rito risulta snaturata, il significato delle singole parti oscurato o travisato, la spiritualità della liturgia distrutta.
Una delle variazioni più frequenti consiste nel recitare ad alta voce le parti che secondo le rubriche vanno dette secreto, trasformando così la Messa in una specie di rappresentazione teatrale, nella quale il pubblico deve udire tutto, e dimenticando i motivi profondi che stanno alla base delle prescrizioni ecclesiastiche. Il tono di voce inintellegibile, infatti, si usa sia per distinguere le parti private (introdotte, cioè, soprattutto per la devozione del sacerdote) dalle parti pubbliche della Messa, sia per ragioni mistiche (come nel caso del Canone, in cui l’uso del tono di voce inintellegibile serve per sottolineare la sacralità e la grandezza dei misteri che in esso si compiono). Eliminarlo o ridurlo a seconda del proprio arbitrio significa alterare la natura del rito, ostacolandone, anziché agevolandone, la fruizione. Lo stesso dicasi per l’introduzione del volgare in parti diverse dalle letture e per altri abusi di minore o maggiore entità.
La conoscenza delle rubriche, naturalmente, è di competenza del sacerdote. Capita spesso, tuttavia, che egli, accostandosi per la prima volta al rito antico, non sappia dove cercare le rubriche che gli interessano o non sia in grado di coordinarle fra loro. Oggi, per fortuna, esistono numerosi sussidi che permettono di rimediare a questa difficoltà. È compito dei laici segnalarli o procurarli al sacerdote. Qui mi limito a indicare i principali.
Innanzi tutto, il video esplicativo della Messa, realizzato a cura della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” e pubblicato sul sito Maranatha. Poi, sempre sullo stesso sito, la traduzione italiana delle Rubriche generali, delle Rubriche generali del Messale Romano e del Ritus servandus: quest’ultimo contiene le istruzioni dettagliate su come celebrare la Messa in forma straordinaria. Ulteriori informazioni si trovano sugli altri siti internet dedicati alla liturgia tradizionale. I più esperti possono ricorrere a un manuale del 1963 recentemente ristampato: L. Trimeloni, Compendio di Liturgia pratica, Milano, Marietti, 2007. Infine, per ordinare le varie parti della Messa a seconda del giorno liturgico, senza dover ogni volta consultare le rubriche, si può ricorrere a un mio lavoro: Ordo Missae celebrandae et divini Officii persolvendi, Danielis Di Sorco cura et studio, Senae, Cantagalli, 2009, che offre anche, nella prima parte, un riassunto schematico delle principali norme.
Non è inopportuno che i laici dotati di una certa competenza rubricale facciano notare al sacerdote le sviste e gli errori che egli commette nel celebrare, purché ciò avvenga con la dovuta delicatezza e solo nel caso di errori ricorrenti. Si ricordi che, se da un lato bisogna evitare la sciattezza, dall’altro non bisogna spingere verso un eccessivo perfezionismo. Per imparare a celebrare bene la Messa tradizionale il sacerdote inesperto ha bisogno di tempo e di esperienza: non avere pazienza nei suoi confronti o pretendere subito una funzione perfetta in ogni dettaglio è semplicemente assurdo.
8. Il servizio all’altare.
Un altro aspetto che richiede la massima cura è il servizio all’altare. Per esso valgono, mutatis mutandis, le stesse considerazioni che abbiamo fatto a proposito del sacerdote: un servizio devoto, attento, rispettoso delle norme sarà motivo di decoro per la funzione e di edificazione per i fedeli; al contrario, un servizio lasciato al caso o affidato a persone impreparate sarà motivo di distrazione e di disordine. Si ricordi che, secondo la citata Instructio della S. Congregazione dei Riti, “i laici di sesso maschile, sia fanciulli che giovani o adulti, quando vengono deputati dalla competente autorità ecclesiastica al ministero dell’altare, […] se assolvono tale ufficio nel modo e nella forma voluta dalle rubriche, esercitano anch’essi un servizio ministeriale diretto, ma delegato” (n. 93 c).
È necessario, quindi, che questo importante incarico sia assunto da persone disposte a svolgerlo nel migliore dei modi. In genere si preferiscano gli adolescenti e i giovani, sia per coinvolgerli più direttamente nella celebrazione nel culto e favorire così eventuali vocazioni al sacerdozio, sia per la loro maggiore predisposizione ad imparare e a memorizzare. Ma non bisogna pensare, come fanno in molti, che il servizio all’altare sia cosa esclusivamente da giovani. Anzi, se i ragazzi che frequentano la Messa tradizionale si rivelassero meno adatti, per ragioni oggettive, a svolgere questo compito, è meglio che se ne faccia carico qualche adulto.
Per imparare a servire all’altare o per verificare se il servizio svolto sia effettivamente conforme alle rubriche, come stabilisce la Instructio testé citata, è possibile valersi di un gran numero di sussidi, disponibili sia su internet sia in formato cartaceo. Tra di essi mi permetto di segnalare un lavoro al quale ho collaborato e che si occupa ex professo dell’argomento: E. Cuneo – D. Di Sorco – R. Mameli, Introibo ad altare Dei. Il servizio all’altare nella liturgia romana tradizionale, Verona, Fede & Cultura, 2008. Per chi può, la soluzione più pratica ed efficace consiste nell’imparare da chi sa già servire.
Si tenga presente, inoltre, che il numero di persone che servono all’altare, secondo le disposizioni della Sacra Congregazione dei Riti, dev’essere regolato in base alla solennità. Esso normalmente è di uno per la Messa letta semplice, due per la Messa letta con qualche elemento di solennità (come, per esempio, la Messa domenicale, la Messa accompagnata, la Messa cum canticis e quando un chierichetto inesperto debba imparare a servire da un altro più esperto) e per la Messa cantata, tre o quattro (due assistenti e turiferaio) per la Messa cantata con incenso, salvo casi particolari. Questo per quanto riguarda il servizio vero e proprio. Ma, per ragioni di solennità o per svolgere mansioni di minor conto, nulla vieta di impiegare un numero maggiore di chierichetti, specialmente nei giorni festivi. In ogni caso, bisogna fare in modo che l’impiego di un servizio numeroso non si risolva in una cattiva suddivisione dei compiti: in certe cappelle non è raro vedere cinque o sei persone che servono una Messa letta e nessuno che si occupa, per esempio, del canto o di altri incarichi.
Della preparazione della chiesa e della manutenzione delle suppellettili potranno occuparsi, a seconda dei bisogni, sia i chierichetti sia qualche altra persona capace e disposta ad assumersi l’incarico. Certamente bisogna evitare che la celebrazione della Messa tradizionale avvenga con arredi non perfettamente puliti. Spetta al gruppo dei fedeli farsi carico, se necessario, di questa grave incombenza.
9. La musica sacra.
Fin qui ci siamo occupati degli elementi indispensabili a tutte le funzioni: il sacerdote celebrante, i ministranti, le suppellettili del culto. Curare attentamente questi tre aspetti comporta già una significativa elevazione delle celebrazioni in forma ordinaria rispetto al livello medio della liturgia attuale. Ad essi può aggiungersene un quarto, che, pur non essendo strettamente indispensabile, riveste un’importanza fondamentale sia in ordine alla solennità e al decoro del culto sia in ordine alla partecipazione attiva dei fedeli. Mi riferisco alla musica e al canto sacro.
È triste dover constatare che spesso le funzioni in forma straordinaria non sono migliori, sul piano musicale, delle funzioni in forma ordinaria. Ancor più triste è accorgersi che ciò avviene non per mancanza di mezzi, ma per negligenza o, quel che è peggio, per pregiudizio verso le funzioni in canto, ritenute addirittura responsabili di ostacolare la partecipazione popolare. Questo spiega perché in molte chiese, anche quando c’è la possibilità di realizzare una Messa in canto, si preferisca la forma cosiddetta dialogata. L’esperienza, tuttavia, dimostra che i fedeli che assistono per la prima volta al rito tradizionale rimangono più colpiti da una Messa in canto o almeno da una Messa cum canticis piuttosto che da una Messa completamente piana.
Del resto, la forma primitiva e originaria della Messa è quella in canto, che pertanto mantiene ancora oggi il massimo grado di coerenza, efficacia e solennità rituale. In antico tutte le celebrazioni erano in canto e tale consuetudine si manitene ancora oggi presso alcune Chiese orientali dissidenti. Soltanto in un secondo tempo, col diffondersi delle Messe private e la conseguente esigenza di semplificare la celebrazione, si addivenne alla forma “letta”. D’altra parte, la partecipazione attiva del popolo al santo Sacrificio è sempre avvenuta attraverso il canto: canto liturgico in latino alle funzioni solenni, canto popolare in latino e soprattutto in volgare alle funzioni lette. La Messa dialogata è relativamente recente (cominciò a diffondersi su larga scala solo a partire dagli anni Venti) e non esclude, ma integra, la partecipazione attraverso il canto.
Pertanto, se si vuole incrementare la solennità e la bellezza delle funzioni in forma straordinaria ed agevolare così la presenza dei fedeli, è necessario curarne di più l’aspetto musicale.
10. La Messa cantata.
L’ideale sarebbe celebrare la Messa cantata ogni domenica. Non si tratta di un obiettivo irraggiungibile neppure per quelle chiese che non possono disporre di un vero e proprio coro. L’Ordinario può essere sempre eseguito dal popolo su melodie semplici e note, come la Missa de Angelis o altre Messe in musica appositamente scelte. Per quanto riguarda il canto del Proprio, molti si lasciano scoraggiare dalle complicate melodie contenute nel Graduale o nel Liber usualis, dimenticando che esse possono essere legittimamente rimpiazzate da un semplice tono salmodico o addirittura dal tono retto (Instructio cit., n. 21 c).
Affinché l’esecuzione dei canti, specialmente di quelli del Proprio, avvenga in maniera decente e ordinata, è opportuno eseguire una piccola prova, anche subito prima dell’inizio della funzione, e costituire un gruppo di persone di buona voce e sicura intonazione che sia in grado di guidare il resto del popolo. Benché in genere sia piuttosto semplice procurarsi un organista, non bisogna vincolare alla sua presenza l’esecuzione dei canti.
A me pare che questo minimum possa essere raggiunto dappertutto. Il popolo non rimane estraneo alla sacra azione, ma vi partecipa nel modo più appropriato, cioè mediante l’esecuzione dei canti liturgici ad esso spettanti. Chi ha mezzi maggiori, naturalmente, può andare oltre e costituire un vero e proprio coro, capace di eseguire pezzi più difficili e più belli (per esempio, le melodie gregoriane del Proprio, canti polifonici, ecc.). Si badi però di lasciare sempre al popolo, salvo casi particolarissimi, l’esecuzione di almeno una parte dei canti della Messa. Una buona soluzione è affidare al coro il Proprio e i mottetti d’Offertorio e di Comunione, riservando al popolo l’Ordinario.
Laddove, per vari motivi, non è possibile celebrare la Messa cantata con frequenza regolare, si cerchi di utilizzare questa forma almeno nelle maggiori solennità. Nelle altre circostanze, la norma dovrebbe essere costituita da una Messa letta non solo dialogata, ma anche cum canticis o almeno accompagnata.
11. La Messa letta dialogata e cum canticis.
Che cosa sia la Messa dialogata tutti lo sanno. In Italia è ormai divenuta la forma normale di celebrazione della Messa letta. Non è quindi il caso di dilungarci troppo su di essa, se non per osservare che, dei quattro grado di partecipazione previsti dalla citata Instructio della S. Congregazione dei Riti (n. 31), il più adatto alle circostanze ordinarie è senza dubbio il terzo, che prevede la recita da parte del popolo delle risposte liturgiche e di alcune parti dell’Ordinario della Messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei), mentre il quarto, come precisa la stessa Instructio, è bene riservarlo a “gruppi scelti di persone colte e ben preparate”, quali le comunità religiose, poiché la recita comune delle parti del Proprio, se non è debitamente preparata in anticipo, si risolve in un confuso affastellamento di voci.
Meno nota e meno praticata della Messa dialogata, ma più tradizionale di questa per origine e per fisionomia, è la cosiddetta Messa cum canticis. Ho detto meno nota perché in genere le norme che regolano l’esecuzione dei canti alla Messa letta sono poco conosciute e spesso per paura di sbagliare si preferisce non fare nulla.
Cominciamo subito col dire che con l’espressione “Messa letta” si intende una Messa nella quale tutte le parti liturgiche, sia quelle dell’Ordinario che quelle del Proprio, sono dette senza canto, ad alta o bassa voce secondo quanto previsto dalle rubriche (Rubricae generales Missalis romani, 271). Ciò non esclude, tuttavia, che nei momenti di silenzio o quando il sacerdote prega prolungatamente sottovoce si eseguano canti religiosi non liturgici, il cui testo, cioè, non è tratto dall’Ordinario o dal Proprio della Messa del giorno. Anzi, i documenti della Santa Sede lo consentono esplicitamente: “Nelle Messe lette i fedeli possono cantare canti popolari religiosi, a condizione però che questi siano strettamente intonati alle singole parti della Messa” (Instructio cit., n. 33). Questi canti prendono il nome di mottetti e, non essendo strettamente liturgici, possono essere sia in latino che in volgare e abbracciare vari generi musicali.
La Messa cum canticis offre dunque l’opportunità di riscoprire ed eseguire nel cuore stesso della liturgia quell’inestimabile patrimonio di canti religiosi popolari tanto caro alla pietà popolare e altrimenti destinato all’oblio. Consente inoltre di temperare quei lunghi momenti di silenzio che per molti, almeno in un primo momento, costituiscono un serio ostacolo alla fruizione della Messa tradizionale. Del resto, se è vero che il silenzio è fondamentale per la meditazione e la preghiera personale, è anche vero che la Messa è specialmente destinata alla preghiera comunitaria e che la Messa in canto non prevede tanto silenzio quanto la Messa letta. Il canto non liturgico, inolte, può essere considerato in qualche modo una forma di silenzio meditato.
A chi oggi dimostra poca simpatia per la Messa cum canticis è opportuno ricordare che questa era tradizionalmente la forma normale della Messa letta nelle domeniche e nei giorni festivi. Nei paesi di lingua tedesca si era arrivati al punto di eseguire i canti popolari anche durante quelle parti che il sacerdote avrebbe dovuto dire ad alta voce. Ciò spiega la presenza di canti, non solo “all’ingresso” o “all’Offertorio”, ma anche “al Gloria“, “al Sanctus” e addirittura “al Vangelo” nella celebre Deutsche Messe di Michael Haydn. Una prassi del genere è certamente eccessiva, poiché sovrappone alla Messa vera e propria una specie di paraliturgia popolare in volgare, ma dimostra comunque la diffusione della Messa cum canticis e l’attaccamento che il popolo dimostrava verso di essa. Personalmente sono convinto che una maggior diffusione di questa forma, integrata e non sostituita alla Messa dialogata, renderebbe le funzioni in forma straordinaria più degne, più solenni, più fruibili anche da parte dei non esperti.
Vengo ora ad alcune indicazioni pratiche. Alla Messa letta i mottetti possono essere eseguiti in tutti o in alcuni dei seguenti momenti: 1) all’ingresso del sacerdote celebrante; 2) mentre il sacerdote recita il Munda cor meum prima del Vangelo; 3) all’Offertorio, da dopo la recita dell’antifona fino alla lavanda delle mani o alla Secreta; 4) dopo il Sanctus fino alla consacrazione esclusa; 5) dopo la consacrazione fino al termine del Canone; 6) dopo l’Agnus Dei fino alla Comunione del celebrante; 7) durante la Comunione dei fedeli; 8) all’uscita del celebrante, dopo l’ultimo Vangelo o le preci leonine.
Quanto al repertorio, la scelta è piuttosto vasta. Si va dai canti popolari o composti ad uso del popolo fino a pezzi più complessi, gregoriani o polifonici, la cui esecuzione può essere in certi casi affidata a un coro. Esistono anche serie di mottetti scritte appositamente per accompagnare la Messa letta. Tra tutte ricordiamo la versione italiana della Deutsche Messe di M. Haydn (Celebre Messa popolare: dieci canti per la messa piana a 4 voci dispari con o senza organo, nuova edizione curata dal M. Francesco Bagnoli. Firenze, Maurri, s.d.) e I canti del popolo alla Santa Messa di D. Bartolucci (Roma, A.I.S.C., 1954). Diverse serie di mottetti, in latino e in italiano, offre il Manuale diocesano pubblicato nel 1955 dell’arcidiocesi di Firenze.
Se si impiegano singoli mottetti, è necessario che essi siano adatti al momento della Messa in cui vengano eseguiti (Instructio cit., n. 30). A puro titolo esemplificativo, si possono menzionare i seguenti canti: Al tuo santo altar all’ingresso; Signor, di spighe indori all’Offertorio; una parafrasi del Sanctus (come È Santo dalla ricordata Messa popolare di Haydn) o un canto di giubilo dopo il Sanctus; un mottetto eucaristico, come Ave, verum o O salutaris, dopo la Consacrazione, dopo l’Agnus Dei e alla Comunione; un mottetto di ringraziamento alla fine. Le possibilità, come ho detto, sono molte; ma certamente non avrebbe senso eseguire un mottetto eucaristico all’Offertorio o un canto di mestizia dopo la Consacrazione. Per la preparazione dei canti, valgono gli stessi consigli dati a proposito della Messa in canto.
12. La Messa “accompagnata”.
Nelle celebrazioni occasionali è talvota difficile organizzare persino una Messa cum canticis. Conviene allora ricorrere ad una forma oggi poco usata ma un tempo molto diffusa, specialmente nei giorni feriali: la Messa cosiddetta accompagnata. Si tratta di una Messa letta durante la quale, negli stessi momenti in cui sono consentiti i mottetti, si suona l’organo (cfr. Instructio cit., n. 29). Se ciò avviene in modo conforme alle diverse parti della liturgia, il suono dello strumento costituisce non un semplice accompagnamento, ma un vero e proprio aiuto alla preghiera e alla meditazione. Naturalmente, è necessario che l’organista abbia le conoscenze liturgiche e musicali sufficienti per svolgere in modo adeguato il proprio compito.
13. Messa letta e Messa in canto.
Chi si occupa dell’organizzazione dei canti e della musica, tanto alla Messa in canto quanto alla Messa letta, deve conoscere dettagliatamente le norme ecclesiastiche in materia, ricavate dalla più volte menzionata Instructio della Sacra Congregazione dei Riti, il cui testo, in traduzione italiana, si trova sul sito Maranatha.
Qui mi preme soltanto ricordare una norma spesso disattesa. La Messa in canto e la Messa letta sono, nel rito tradizionale, due forme ben distinte. Pertanto non è consentito celebrare una Messa in parte letta e in parte cantata, ossia una Messa letta nella quale soltanto alcune parti dell’Ordinario e del Proprio sono eseguite in canto.
Le ragioni di tale proibizione sono varie. In primo luogo, si tratta di conservare la specificità della Messa in canto, che è la forma originaria della Messa, impedendo il diffondersi di forme ibride, le quali, come è avvenuto nella liturgia ordinaria, finirebbero per sostituirsi completamente ad essa. In secondo luogo, è necessario mantenere la differenza funzionale tra parti in canto e parti lette, differenza che rimanda alla loro diversa origine e alla loro diversa destinazione.
Dell’argomento mi sono occupato più specificamente nel mio libro Introibo ad altare Dei cit., pp. 171-186. Naturalmente la proibizione di eseguire canti liturgici alla Messa letta non si riflette sulla possibilità di cantare mottetti, i quali, come abbiamo visto, sono canti religiosi su testo non liturgico.
È necessario ribadire che un ibrido tra Messa in canto e Messa letta, alterando l’economia e l’equilibrio del rito, non ne agevola la fruizione da parte dei fedeli, ma la ostacola e la confonde.
14. La catechesi liturgica.
Fin qui ci siamo occupati di come realizzare la funzione. Fatto questo, occorre fornire ai fedeli, specialmente ai nuovi arrivati, i mezzi adeguati sia per comprenderla che per seguirla.
Al primo obiettivo si provvede con la catechesi liturgica. È vero che la forma straordinaria è assai espressiva sul piano spirituale e quindi, in un certo senso, parla da sola, ma è anche vero che il rito, come qualunque linguaggio simbolico, ha bisogno di essere spiegato. Tale esigenza diventa ineludibile in tempi come questi, quando i fedeli, specialmente i più giovani, hanno una nozione incompleta o inesatta non solo dei singoli gesti liturgici, ma anche del significato stesso della Messa. Come si può rimediare? I mezzi più indicati mi paiono due.
In primo luogo, un ciclo di brevi momenti di istruzione liturgica, della durata di non più di cinque minuti, da tenersi prima dell’inizio della funzione. Essi dovrebbero essere dedicati prima alla presentazione generale della liturgia antica e poi alla spiegazione delle singole parti del rito, con particolare attenzione alla loro valenza spirituale. Di tale incarico è bene che si occupi un sacerdote o, in sua mancanza, un laico esperto. Come modello possono essere usati i catechismi liturgici popolari in uso prima della riforma. Ricordo in particolare quello riportato nell’opuscolo del card. G. Lercaro A Messa, figlioli! (Bologna, 1955; di tale sussidio è raccomandabile la parte catechetica, non quella direttiva sulla Messa) e modellato sul catechismo di S. Pio X. Oltre a questo, non sarebbe inutile organizzare un ciclo di conferenze vere e proprie, seguite o meno dalla celebrazione della Messa, per illustrare più nel dettaglio le caratteristiche del rito.
Nella catechesi liturgica è particolarmente importante ricordare ai fedeli un principio che, per quanto ovvio, è da molti dimenticato: alla Messa si va non tanto per ascoltare, quanto per pregare. Il nuovo rito, con l’uso esclusivo del volgare e della voce intellegibile, ha fatto sì che molti concepiscano la Messa alla stregua di un’opera teatrale, in cui ciò che conta è vedere tutto, sentire tutto, capire tutto. Non si comprende più che nella Messa la dimensione esteriore è ordinata a quella interiore e che al momento dell’ascolto e della preghiera comunitaria deve fare riscontro il momento del raccoglimento e della preghiera personale. Nel rito antico questo aspetto è ben presente, soprattutto grazie ai lunghi momenti di silenzio. Bisogna fare in modo che i fedeli, specialmente quelli abituati alla forma ordinaria, ne abbiano coscienza, se si vuole evitare che, durante l’offertorio o il canone, restino confusi e disorientati sul da farsi.
Non sempre, tuttavia, la catechesi liturgica è possibile, specialmente in quei contesti in cui il sacerdote non sia disposto a farla e i fedeli si sentano inadeguati al compito. Inoltre essa, per la sua brevità, risulta utile solo a coloro che frequentano la Messa antica abitualmente, mentre dice poco a chi vi assiste una volta ogni tanto o decide di andarvi per semplice curiosità. Allora sarà opportuno, in sostituzione o in aggiunta a questi brevi momenti di istruzione, tenere a disposizione dei fedeli, su un tavolo collocato in fondo alla chiesa ma ben visibile, alcune pubblicazioni dedicate proprio alla spiegazione della Messa tradizionale nei suoi aspetti liturgici e spirituali.
Particolarmente adatti allo scopo sono due opuscoli recentemente ristampati dalle Suore Francescane dell’Immacolata di Città di Castello: La santa Messa di Dom Prosper Guéranger, capolavoro della divulgazione liturgica del XIX secolo e validissimo ancora oggi, e Questa è la Messa di Henri Daniel-Rops, più sintetico ma perfetto per approfondire la spiritualità del rito antico. Oltre all’indubbio pregio di essere accessibili a qualunque persona di media cultura, questi libretti hanno il vantaggio di essere venduti ad offerta libera. Qualunque coetus fidelium, quindi, può acquistare senza difficoltà un certo numero di copie e metterle a disposizione, sempre ad offerta libera, dei frequentatori della Messa. Naturalmente esistono molte altre ottime pubblicazioni sull’argomento. Si evitino, però, le opere troppo specialistiche o troppo polemiche. Una volta dotato degli strumenti necessari per comprendere la Messa nella sua essenza liturgica, il fedele sarà in grado da sé di fare il confronto tra l’antico e il nuovo rito.
15. Il messalino.
Il secondo mezzo per rendere familiare alle persone di oggi la liturgia in forma straordinaria è un sussidio da tutti riconosciuto utile ma da molti trascurato. Mi riferisco al messalino o al libretto che riporta il testo della Messa in latino e in traduzione italiana. L’uso di un libretto da leggere durante la funzione per seguirla con maggior profitto spirituale è antichissimo. Nel secolo scorso, grazie all’alfabetizzazione delle masse, ricevette una diffusione capillare. Si stampavano messalini di ogni genere e per ogni categoria di persone: dal semplice opuscolo devozionale con preghiere da recitare privatamente nei vari momenti della funzione (si ricordi, fra tutti, quello compilato da S. Alfonso Maria de’ Liguori), al messale bilingue vero e proprio. Qualunque cattolico “praticante” ne possedeva almeno uno, regalatogli, magari, al momento della prima Comunione o della Cresima.
Oggi la situazione è molto cambiata. I messalini sono caduti quasi dappertutto in disuso. Al contrario, il desiderio di seguire la Messa su un sussidio cartaceo non è affatto scomparso, neppure per il rito nuovo. Di qui la grande diffusione di foglietti che quasi ogni parrocchia mette a disposizione ogni domenica dei propri fedeli.
Ma se alla Messa in italiano si sente ancora l’esigenza di avere sotto gli occhi il testo della funzione, che dire, allora, della Messa in latino, in cui la lingua costituisce per molti un ostacolo? Senza nulla togliere all’importanza della preghiera, della meditazione, dell’adorazione, è evidente che alcune parti della Messa sono espressamente destinate all’istruzione del popolo e, come tali, devono poter essere seguite da tutti. Il messalino poi, oltre a permettere di seguire punto per punto la funzione, ha un’altra, ben più importante funzione. Consente di avere un’idea più chiara della Messa, di inquadrarne meglio la struttura, di ricordarne più efficacemente le preghiere: consente, in altre parole, di conoscere meglio il rito e di assistervi con maggior frutto spirituale. In questo senso, un buon messalino è il necessario complemento della catechesi e degli opuscoli di divulgazione liturgica.
Questa duplice valenza del messalino è sottolineata da Pio XII nella sua celebre enciclica Mediator Dei sulla sacra liturgia: “Sono degni di lode coloro i quali, allo scopo di rendere più agevole e fruttuosa al popolo cristiano la partecipazione al Sacrificio Eucaristico, si sforzano di porre opportunamente tra le mani del popolo il «Messale Romano», di modo che i fedeli, uniti insieme col sacerdote, preghino con lui con le sue stesse parole e con gli stessi sentimenti della Chiesa”.
16. Quali caratteristiche per il messalino?
Per riuscire veramente utile, tuttavia, il messalino (o il foglietto che lo sostituisce) deve avere caratteristiche ben precise.
Innanzi tutto, il testo della Messa e la sua traduzione volgare devono essere integrati da indicazioni di carattere liturgico e spirituale, non troppo prolisse ma neppure troppo scarne che spieghino con una certa chiarezza sia la natura dei singoli momenti liturgici, sia le loro caratteristiche rituali, sia l’atteggiamento esteriore ed interiore che i fedeli sono invitati ad osservare durante ciascuno di essi. Un messalino ben fatto, tanto per limitarci a qualche esempio, dice quali parti saranno dette ad alta voce e quali sottovoce; fa le debite distinzioni tra Messa in canto e Messa letta, laddove queste comportino modifiche allo svolgimento del rito (per esempio, non si può non specificare che alla Messa in canto le preghiere ai piedi dell’altare sono dette sottovoce dal sacerdote e dai suoi assistenti mentre il coro canta l’antifona all’Introito); invita al raccoglimento e all’adorazione quando il sacerdote prega a lungo sottovoce, in particolare durante il Canone; delinea per sommi capi la natura e lo scopo delle singole parti della Messa; fornisce, in poche parole, tutte le indicazioni necessarie per seguire con profitto la funzione.
Certo, bisogna trovare il giusto equilibrio tra completezza e concisione. Un messalino con note eccessivamente lunghe sarebbe illeggibile. D’altra parte, un messalino senza note sarebbe praticamente muto, specialmente per il fedele di oggi, che il rito antico non lo conosce. Inoltre, bisogna pensare al messalino come ad un sussidio che si consulta anche fuori dalla Messa, per conoscere, meditare, approfondire.
In secondo luogo il testo della Messa e la relativa traduzione devono essere completi, senza tagli od omissioni. Qualcuno obietterà che in questo modo si rischia di disorientare i fedeli alle prime armi, incapaci di districarsi tra le varie parti del rito. Meglio sarebbe, secondo costoro, riportare per intero soltanto le sezioni dette a voce alta o in canto e riassumere le altre in brevi note esplicative. Ora, non nego che una versione abbreviata del testo della Messa possa risultare, per certi versi, più pratica e maneggevole. Ma mi domando: che idea riesce farsi del rito tradizionale un fedele che sul messalino non trovi il testo di due preghiere così caratteristiche di questa forma liturgica, come l’Offertorio e il Canone, che sono dette sottovoce? E come può seguire con profitto la Messa servendosi di un sussidio del genere?
Si consideri che quasi tutti i messalini d’epoca riportano il testo liturgico per intero. Perfino l’opuscolo di S. Alfonso, espressamente destinato al popolo, contiene quasi la maggior parte dell’Ordinario in traduzione volgare, sia pur parafrasata e abbreviata in qualche punto. E ciò avveniva quando i fedeli, pur recitando talvolta il rosario od altre devozioni private durante la Messa, ne conosceva alla perfezione lo svolgimento, nella successione dei singoli momenti. A maggior ragione, oggi che i fedeli hanno pochissima familiarità col rito antico, la completezza del testo riportato dal messalino è una necessità ineludibile.
17. Stampa dei messalini.
Come provvedere ad un messalino per tutti? Chi frequenta assiduamente la Messa in forma straordinaria è opportuno che acquisti un messalino vero e proprio, meglio se quotidiano, da utilizzare sia per seguire la Messa sia per la meditazione o l’approfondimento del rito a casa propria. Se ne trovano ancora diverse copie presso le librerie antiquarie e i siti internet specializzati in libri usati; potendo scegliere, si preferiscano le edizioni dal 1960 al 1964, in quanto conformi nei testi e nelle rubriche al Messale romano del 1962. Recentemente alcune case editrici hanno ristampato un messalino latino-italiano per la forma straordinaria.
Tra tutti, il migliore è, a mio avviso, quello della Marietti (Dom Gaspare Lefebvre O.S.B., Messale romano quotidiano, a cura dell’Apostolato Liturgico di Genova, Torino, Marietti, 1963; ristampa anastatica: Milano, Marietti 1820, 2008), il cui costo, forse un po’ eccessivo, è ampiamente ripagato dalla completezza del testo (vi sono infatti riportate tutte le Messe dell’anno liturgico, le Messe votive, il rito dei sacramenti, di alcuni sacramentali e delle principali devozioni), dall’accuratezza della traduzione e del commento, e dalla bellezza tipografica dell’edizione.
Per coloro che seguono la Messa solo saltuariamente o non hanno intenzione di spendere molto denaro, si deve provvedere con libretti stampati in proprio dal coetus fidelium e distribuiti alla porta della chiesa. La soluzione più pratica e più economica consiste nel disporre di due sussidi distinti: un libretto (rilegato a punto metallico) con l’Ordinario e le indicazioni liturgico-pastorali, da usare a tutte le Messe, e un foglietto col Proprio del giorno, da sostituire di volta in volta.
Un sito internet mette a disposizione gratuitamente i testi, già impaginati e pronti per la stampa, di tutte le Messe dei giorni di precetto: lavoro senza dubbio meritorio, di cui tuttavia non possiamo non mettere in evidenza due limiti. In primo luogo, l’aspetto grafico lascia molto a desiderare, tanto da rendere difficile a molti l’identificazione delle varie parti della Messa. In secondo luogo, i libretti riportano il testo di tutta la Messa, Proprio e Ordinario insieme, costringendo, ogni volta, a stampare un gran numero di pagine. Infine, certi messalini non sono conformi all’edizione del Messale del 1962.
Sarebbe auspicabile, invece, che si mettesse a disposizione un Ordinario della Messa corredato da indicazioni (come quello pubblicato sul sito Maranatha, raccomandabile anche per la cura dell’aspetto grafico, anche se il grande formato delle pagine ne rende scomodo l’utilizzo) e una serie di foglietti riportanti solo il Proprio del giorno.
18. Il punto della questione.
Giunti a questo punto del mio articolo, alcuni osserveranno che ho tentato di affrontare un problema molto serio parlando di minuzie. Il che è senz’altro vero. Solo che, come si dice, è la somma che fa il totale. E in un ambito come quello liturgico, la cura delle minuzie riveste un’importanza che non esito a definire essenziale. Se oggi la liturgia è oggetto dei più gravi scempi, lo dobbiamo all’atteggiamento di chi, in un pericoloso gioco al ribasso, ostenta di curarsi soltanto dello stretto necessaro e di trascurare il superfluo. Spingendo questo ragionamento alle sue logiche conseguenze, alcuni sacerdoti considerano intangibile, nel rito della Messa, soltanto la formula della consacrazione: tutto il resto può variare a piacimento.
Dobbiamo evitare che questo errore, molto più diffuso di quanto si creda, si rifletta sulle funzioni in forma straordinaria, anche se in modalità meno estreme o meno riconoscibili. Ecco perché, a mio avviso, le minuzie di cui mi sono occupato in buona parte del mio articolo sono il punto di partenza indispensabile per fare della Messa tradizionale una funzione non solo bella ed edificante, ma anche fruibile da parte dei non iniziati.
Opposta a questa posizione è quella di chi, pur riconoscendo la fondatezza delle mie proproste, dubita della loro reale fattibilità, almeno nelle circostanze attuali. Com’è possibile, si chiedono costoro, realizzato una funzione che abbia tutte le caratteristiche delineate sopra, se i fedeli che vi partecipano sono pochi e, tra quei pochi, pochissimi sembrano disposti ad assumersi degli incarichi?
19. Dal coetus fidelium alla comunità.
Questa domanda ci conduce alla questione centrale di cui ho parlato all’inizio del mio contributo: trasformare il “centro di Messa” in una vera e propria comunità, capace non solo di far fronte alle necessità pratiche della funzione, ma anche di favorire la crescita spirituale dei suoi membri. Le difficoltà, come abbiamo visto, sono molte, ma hanno, a mio avviso, una radice comune: la mancanza di coesione. Se i fedeli che frequentano la Messa in forma straordinaria fossero più uniti, se tra loro ci fosse un po’ più di familiarità, individuare i problemi e prospettarne la soluzione non sarebbe poi così difficile. In genere, però, le cose vanno in modo del tutto diverso. Non tanto per diffidenza (poiché l’ambiente dei gruppi legati alla liturgia antica non è affatto, come qualcuno potrebbe immaginare, chiuso od elitario), quanto per ragioni oggettive, quali la scarsa frequenza della Messa e delle altre occasioni di ritrovo, l’imbarazzo di fare qualche parola subito prima o subito dopo l’inizio della funzione, la differenza di età e di ambiente sociale.
Quale rimedio? Non è semplice dare una risposta univoca, che vada bene per tutti i gruppi e sia adatta a tutte le circostanze. Qualunque proposta, poi, ha da essere modellata nel concreto della realtà locale. Mi limiterò pertanto ad esporre una soluzione che in Toscana è stata applicata in molte diocesi con discreto successo: quella dell’associazionismo. Si tratta, in poche parole, di raccogliere i fedeli più attivi ed interessati in un’associazione che abbia lo specifico compito di curare l’organizzazione e diffondere la conoscenza della liturgia in forma straordinaria.
Può sembrare, a prima vista, che questa idea abbia ben poco di originale. Associazioni con scopi analoghi a quelli da me delineati esistono già da tempo. Molti centri di Messa, in Italia e nel mondo, fanno capo ad esse. E questo non ha evitato che si verificassero gli inconvenienti denunciati nel presente contributo. A che scopo, allora, riproporre una soluzione che da questo punto di vista si è rivelata inefficace?
20. Il modello associativo.
È evidente che bisogna far riferimento ad un modello associativo diverso da quello attualmente più diffuso. Le grandi organizzazioni storiche hanno due caratteristiche fondamentali: la centralizzazione e le grandi dimensioni. Esse sono costituite da una miriade di sezioni locali, le quali, pur godendo di qualche autonomia, adottano uno statuto e un sistema di funzionamento uguale per tutte. Un modello del genere era di grandissima utilità prima del motu proprio, quando i singoli gruppi, per ottenere la Messa tradizionale dal proprio Vescovo, dovevano quasi necessariamente far capo ad una istituzione più grande e più prestigiosa che li sostenesse nella loro richiesta. Oggi molte cose sono cambiate. Se da un lato è più semplice avviare una celebrazione, dall’altro è più difficile gestirla. Non si tratta più di un rito concesso per indulto ad un gruppo ristretto, ma di una forma liturgica che ha riacquistato pieno diritto di cittadinanza nella Chiesa.
In un contesto simile, è necessario, a mio avviso, privilegiare l’organizzazione locale: ogni gruppo costituisce la propria associazione, con uno statuto e un funzionamento adeguato alle proprie esigenze. Ci si domanderà quale debba essere la fisionomia propria dell’associazione locale e in che modo sia possibile realizzarla nel concreto. Mi limito ad alcune considerazioni di base, visto che le necessità particolari a cui far fronte variano molto da luogo a luogo.
In primo luogo, l’associazione locale dovrebbe tenersi alla larga sia da strutture troppo pesanti sia dalla trappola della destrutturazione. Istituire un numero eccessivo di cariche o complicare a dismisura il funzionamento degli organi equivale a paralizzare il funzionamento dell’associazione prima ancora di averlo avviato. Un risultato analogo, tuttavia, si consegue anche con l’atteggiamento diametralmente opposto, vale a dire facendo a meno di qualunque ruolo direttivo e rimettendo tutto alla decisione dell’assemblea. In quest’ultimo caso, costituire l’associazione sarebbe perfettamente inutile, poiché essa non avrebbe nulla di diverso dal gruppo non costituito.
La scelta migliore, come l’esperienza dimostra, è una via di mezzo tra i due estremi: una struttura leggera, in cui l’assemblea dei soci è affiancata da due o tre cariche direttive (presidente, segretario, tesoriere o simili) con incarichi ben determinati. Il potere decisionale, specialmente sulle questioni più importanti, resta all’assemblea, che però affida al consiglio direttivo gli incarichi esecutivi e di rappresentanza. In questo modo diventa molto più semplice far fronte alle necessità pratiche della Messa, organizzare iniziative per diffonderne la conoscenza ed anche confrontarsi col clero. Avere di fronte un’associazione costituita e compatta, infatti, è molto diverso dall’avere di fronte un gruppo sparso e dai confini evanescenti.
Altra caratteristica imprescindibile di qualunque associazione costituita è uno statuto nel quale, brevemente e chiaramente, siano delineate finalità del gruppo, funzionamento e competenze degli organi, modalità di ammissione (e di espulsione) dei membri. Ogni gruppo, come si è detto, provvede a seconda delle proprie esigenze, magari consultando, a titolo esemplificativo, lo statuto di associazioni simili già esistenti.
Non sarà inutile, tuttavia, spendere qualche parola sulle finalità. Più di una volta si è registrata la tendenza a sposare la causa della Messa tradizionale con ideologie politiche od opinioni teologiche che costituiscono ancora libera materia di discussione (come quella relativa al valore e alle implicazioni dei documenti del Concilio Vaticano II). Naturalmente qui non ci riferiamo al patrimonio dottrinale, storico, culturale che soggiace alla Messa in forma straordinaria e che sarebbe assurdo separare da essa, bensì a idee che con la liturgia antica hanno poco o nulla a che fare. In questo modo si corrono due grandi rischi: primo, allontanare tutte le persone che non condividono certe posizioni ideologiche; secondo, creare nell’immaginario collettivo un indebito collegamento tra queste posizioni e la Messa antica in quanto tale. Con presupposti del genere, al di là del giudizio di merito che si voglia dare su di essi, si finisce per inibire, anziché promuovere, la fruizione della liturgia tradizionale da parte dei non iniziati (e, a seconda delle idee in questione, anche da parte degli iniziati). Perciò lo statuto, nell’elencare le finalità dell’associazione, deve tenersi lontano, a mio avviso, da qualunque deriva ideologica. Limitarsi agli scopi pratici e ad un richiamo, conciso ma doveroso, alla dottrina e alla tradizione cattolica è quasi sempre la scelta migliore.
21. Suggerimenti su come costituire e far funzionare un’associazione.
Come si procede, nella pratica, a costituire e far funzionare l’associazione? Si comincia con un ristretto gruppo di persone che decide di prendere l’iniziativa. Può bastare anche una sola persona, purché motivata. Si prosegue col diffonderla presso amici e conoscenti che potrebbero essere interessanti e col mettere un avviso sui siti internet specializzati nella divulgazione della liturgia tradizionale: in questo modo è possibile entrare in contatto con un buon numero di persone, anche al di fuori della propria cerchia di conoscenze. Naturalmente, se nella propria zona si celebra già la Messa antica, l’idea dell’associazione andrà proposta anzitutto ai suoi frequentatori, senza però trascurare i due metodi sopra ricordati. Si organizza quindi una riunione di tutte le persone interessate allo scopo di decidere il da farsi, dotandosi possibilmente, fin dalla prima volta, di cariche provvisorie e di una bozza di statuto, che sarà poi definita e precisata negli incontri successivi.
È tutto: l’associazione è fatta. Ciò che ora conta è farla funzionare. Prima di tutto, alle cariche direttive dovrebbero essere elette persone che si distinguano non solo per competenza, ma anche per equilibrio e saggezza. Un’associazione con un direttivo troppo impulsivo o troppo inerte è destinata al fallimento. In secondo luogo è necessario programmare nel dovuto modo le diverse attività di cui l’associazione vuole farsi carico. Per ciò che riguarda gli aspetti pratici della funzione liturgica, bisogna provvedere a suddividere gli incarichi e ad assegnarli alle persone più adatte. Sarebbe opportuno, anzi, che in seno ad ogni associazione di questo tipo vi fossero due piccole “commissioni”, una per la liturgia (col compito di tenere la sacrestia, predisporre l’altare, assicurare il servizio) e una per la musica sacra (col compito di preparare ed eseguire i canti, suonare l’organo, approntare i libretti per i fedeli). Un altro gruppo potrebbe occuparsi dei messalini e dei foglietti. Un altro ancora avere l’incarico di organizzare attività extraliturgiche interne od esterne al gruppo. Si potrebbero fare molti altri esempi: ogni associazione saprà regolarsi in base alle proprie necessità. Tutto questo, però, ha come presupposto imprescindibile una struttura capace di coordinare gli sforzi e le capacità dei singoli.
Si tenga presente che per costituire un’associazione di questo tipo non è necessario alcun riconoscimento, né civile, né canonico. La legge italiana, infatti, contempla l’esistenza di associazioni private non ufficialmente riconosciute, mentre il codice di diritto canonico non richiede, per le associazioni private di fedeli, l’esplicita approvazione dell’autorità ecclesiastica, se non per l’acquisizione della personalità giuridica (cann. 321-325).
Bisogna evitare, inoltre, di identificare completamente l’associazione col gruppo di fedeli che frequenta la Messa in rito antico. È evidente che molti, per diverse ragioni, non vorranno farne parte. Del resto, per riprendere la figura evangelica utilizzata all’inizio del presente contributo, l’associazione deve configurarsi come lievito che fa gonfiare la pasta, non essere, essa stessa, la pasta. Infine, le associazioni locali sul modello qui proposto non soppiantano, ma integrano, l’opera delle associazioni storiche a struttura centralizzata.
22. I coordinamento di associazioni.
A molti un progetto del genere potrà sembrare utopico. L’esperienza della Toscana dimostra che, con un po’ di buona volontà, non è difficile realizzarlo. Resta il fatto che in alcuni casi, più che l’iniziativa, manca l’esperienza: non si sa in che modo cominciare. In altri, le associazioni locali sono prive delle competenze necessarie. In altri ancora non si sa dove trovare i mezzi per organizzare certe iniziative.
A questi inconvenienti, rifacendoci ancora una volta alla situazione toscana, si può in parte rimediare con un coordinamento regionale. Anche in questo caso, si tratta di una istituzione nuova non nell’idea ma nel modello. Il coordinamento non è una grande associazione che assorbe in sé quelle esistenti, ma una federazione, che, pur dotandosi di un proprio statuto e di proprie cariche, mantiene intatta l’autonomia delle associazioni che ne fanno parte. Queste conservano il loro statuto e il loro funzionamento, ma decidono, mediante il coordinamento, di collaborare con le associazioni di una certa area geografica. Gli scopi, essenzialmente, sono quattro: unire le forze, facendo in modo che i gruppi membri si prestino reciproco aiuto; organizzare iniziative comuni, tra cui, almeno una volta l’anno, un grande evento a livello regionale; rappresentare le associazioni e i loro interessi di fronte alla conferenza episcopale regionale e, nei casi più importanti, anche di fronte ai singoli Vescovi; aiutare la costituzione di nuovi coetus fidelium e collaborare con loro nell’avviare la celebrazione stabile della Messa. Per quanto riguarda la struttura del coordinamento, valgono le stesse indicazioni date a proposito dell’associazione. L’esperienza, ancora una volta, insegna che, quando i presupposti sono buoni, i risultati non si fanno attendere.
23. Azione e contemplazione.
Termino il mio lungo contributo con una nota di carattere spirituale. Quando si è di fronte al problema della frequenza dei fedeli alla Messa in forma straordinaria, così come quando si è di fronte a qualunque difficile problema, agire è importante, pregare lo è di più. L’episodio evangelico di Marta e Maria ce lo insegna. E lo stesso Salvatore lo ribadisce a chiare lettere: “Sine me nihil potestis facere” (Ioann. 15, 5). A volte sembra di riscontrare, anche negli ambienti legati all’antico rito, un residuo di quello stesso appiattimento immanentista che caratterizza tanta parte del mondo cattolico odierno. È un errore che bisogna fuggire ad ogni costo. Ben venga l’analisi dei problemi, la proposta di soluzioni, l’impegno nel metterle in pratica: vi abbiamo dedicato, con questo articolo, non piccola parte del nostro tempo. Ma non si dimentichi il primato della preghiera, delle buone azioni, dei sacrifici offerti per le nostre rette intenzioni: in una parola, il primato della contemplazione sull’azione. Senza questo, tutto il nostro impegno non serve a nulla.